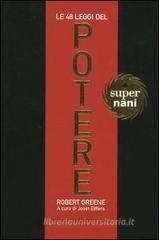Ricordo di aver letto su “Chronicles, vol. 1”, l'autobiografia del giovane Bob Dylan, di come, una sera, il Vate, seduto in macchina con Robbie Robertson di The Band si sentì porre la seguente domanda: “Dove hai intenzione di portarla?” (o era qualcosa del genere... n.d.a.). Di primo acchitto le ipotesi che lo sventurato Bob dovette prendere in esame erano due: A) la domanda riguardava l'itinerario che i due stavano seguendo in auto (domanda: dove hai intenzione di portarla?, risposta possibile: a Fregene.)
Ricordo di aver letto su “Chronicles, vol. 1”, l'autobiografia del giovane Bob Dylan, di come, una sera, il Vate, seduto in macchina con Robbie Robertson di The Band si sentì porre la seguente domanda: “Dove hai intenzione di portarla?” (o era qualcosa del genere... n.d.a.). Di primo acchitto le ipotesi che lo sventurato Bob dovette prendere in esame erano due: A) la domanda riguardava l'itinerario che i due stavano seguendo in auto (domanda: dove hai intenzione di portarla?, risposta possibile: a Fregene.)
B) la domanda era inerente a qualcosa di recondito nella mente di Robbie Robertson e dunque, l'unica scappatoia era rispondere con un'altra domanda e così fece Bob; Bob guardò Robbie e disse: “Cosa?”. Risposta di Robbie Robertson: “Come cosa? La scena musicale! La musica!”... e il povero Bob cadde in depressione per la milionesima volta.
Una cosa che emerge chiaramente dall'autobiografia di Bob Dylan è il fatto che rispetto alla notorietà e all'importanza che TUTTI gli attribuivano, lui nutriva di sé un'opinione ben più sobria, e di tutto quel casino che si faceva intorno alla sua icona ne avrebbe fatto volentieri a meno.
Adesso, noi potremmo anche malignare sul fatto che è tipica delle grandi star questa distaccata versione di se stessi: umilmente Immortali. E però resta la sensazione che al fondo di Bob Dylan tutta 'sta storia rompesse genuinamente il cazzo.
La manfrina appena conclusasi serve ad introdurre una band su cui l'ombra lunga di Dylan si estende come la luce della luna in una limpida notte nella valle della morte. La band: i Felice Brothers.
Come al solito arrivo tardi e sempre con versioni parziali della realtà, rivedibili in secondo grado e perfino ribaltabili in cassazione. Le mie sentenze si fanno via via più approssimative e più che a questioni di tempo credo le ragioni profonde dell'attenuarsi della mia lapidarietà siano da ascrivere all'anagrafe. Con l'età, cioè, sto perdendo la tendenza alla santificazione e conservo solo una sana intolleranza verso ciò che non potremmo definire in altro modo se non come: MERDA.
Dunque, per chiarire, sto parlando qui di UN SOLO DISCO, che può o meno definire interamente il carattere di una band.
Nel mio caso The Felice Brothers sono per me una piacevole sorpresa, soprattutto se letti con la lente che ho cercato di fornirvi nell'introduzione.
La letteratura, il gossip, la critica musicale e una consistente parte del sentire popolare mondiale hanno sempre preso Bob Dylan molto sul serio. I Dylaniani sono spesso persone pesanti e monocorde che in ossequio ad una ortodossia tutta “Dylaniana” fraintendono grossolanamente il messaggio che da sempre il loro menestrello diletto cerca di comunicare. Non dico tutti ma una buona parte di essi è così.
Ma, per fortuna, mentre ancora si dibatte sulla presunta o meno valenza politica di Mozambique, sulle strade mai abbastanza affollate d'America, gli americani fanno del loro patrimonio culturale il cazzo che gli pare. E, aggiungo di mio pugno: MENO MALE!
Dalla culla del dylanismo fricchettone e spiritualista, da quella stessa Woodstock dove Dylan andò ad abitare per ritrovarsi con gli hippies dentro casa che gli chiedevano “L'illuminazione” mentre lui doveva andare a pisciare (pessima idea Bob n.d.a) ecco che escono fuori The Felice Brothers: una versione possibile di un Dylanismo contemporaneo.
La voce del cantante, Ian Felice, che del nostro Bob ricalca senza vergogna toni, inflessioni, e financo la vena ritmica-strofica, insieme con un sound PENSATO e SENTITO e, ovviamente, costruito su Highway 61 piuttosto che Blood on the tracks, The Felice Brothers suonano DIVERTENDOSI. Il che, lasciatemelo dire, è TUTTO!
Siamo lontani da quella che su un Tom Petty possiamo definire come “influenza fondante”, o su di un Elliot Murphy “Vorrei ma non posso”; siamo lontani dalla ricerca di un novello Dylan (portata avanti da un mercato musicale che, ad un certo punto, per pararsi il culo, prende per morto un'artista ancora vivo e attivo e sforna prodotti variamente buoni o scadenti tutto purché abbiano il marchio “Dylan” impresso addosso...) che produsse figure di buona caratura come Willie Nile, buona caratura sì ma imparagonabile con quella della fonte primaria.
Qui, in casa Felice, Bob Dylan lo si è mangiato a merenda come, a suo tempo, Dylan stesso avrà mangiato, che ne so, Pete Seeger (quello che voleva staccargli la corrente a Newport quando si presentò con le chitarre elettriche, per intenderci).
E dunque, la versione che The Felice Brothers propongono oggi di quel sound è fresca e attuale come lo sono i Fleet Foxes per altre cose.
Ho trovato, nell'album ascoltato – il terzo in ordine d'uscita, omonimo, datato 2008 – una scrittura saggia, intrigante e disinibita. Viene riletta la bibbia elettrica del menestrello di Duluth senza timori reverenziali, con modernità e intelligenza; con accostamenti di vecchio e nuovo – penso al finale della quarta traccia in cui si profilano sonorità che definirò per mio comodo “drones dal sapore folk” – con soluzioni valide a prescindere dal fatto che la band si definisca attraverso l'INFLUENZA per eccellenza di un bianco americano di provincia.
L'ho detto già, lo ripeto: ciò che conforta è che nel suonare sotto l'influenza di Bob Dylan, The Felice Brothers si divertono. Come pure è lampante che si divertano a SCRIVERE sotto detta influenza.
La materia è diventata plasmabile; oggi, finalmente, ho trovato una rilettura dell'ebreo sonante che vada oltre l'adorazione incondizionata e la trasfigurazione; oggi, ho capito che mentre da qualche parte ancora si dibatte su Dylan con l'impostazione che avevano le riunioni di Lotta Continua, da qualche altra parte si ASCOLTA attentamente e, cosa più essenziale, si TRAMANDA.
Il linguaggio Dylaniano, questo immutabile leviatano dai molti tentacoli, sta diventando, nel nostro tempo, un giocattolo come un altro: digerito nelle regole di funzionamento, compreso nelle dinamiche e nelle varianti di gioco, finalmente dilettevole.
Situato nel bel mezzo della loro produzione, “The Felice Brothers” (nome della banda e del disco, in questione) porta con se una buona notizia e tramanda con gusto l'immortale e splendido messaggio del nostro Bob: “Suona e fa’ quello che ti pare”.
Prestategli orecchio.